Il
ladro Autolico, convinto sin dalla nascita di essere un fallito, fugge con il
bottino della sua prima rapina e si inoltra nella Foresta degli Spettri, solo
per incontrare un orrendo mostro gelatinoso pronto a ghermirlo con i suoi tentacoli.
Il fabbro Kowen salva una ragazza dalle molestie del figlio dell’Esarca di Nea
Beograd, provocando per caso la morte di quest’ultimo; inseguito dalla Guardia
Civica, monta a cavallo e abbandona il suo paese natio. La sacerdotessa Crise è
tormentata da giorni da un incubo ricorrente, da cui si sveglia, madida di
sudore, ma con in mente un pensiero ricorrente: una voce nascosta sussurra un
nome e l’immagine - sempre più definita - della città di New Haven. Hoenir il
druido, un giovane apprendista che ha dedicato la sua vita allo studio della
natura, è riuscito, nelle sue meditazioni, a entrare in contato con le Driadi,
le Ninfe del bosco.
I
quattro personaggi sono destinati a incontrarsi, dopo molte peripezie, alla
Locanda del Drago Rosso di New Haven, uno dei borghi più importanti delle Terre
Desolate.
A
questo punto entra in scena il saggio Daeron, che si trova a New Haven alla
ricerca di un libro proibito e del senso di una misteriosa profezia. Una setta maledetta, la Chiesa dei Figli
dell’Oscurità, ha tramato e tuttora trama nell’ombra, nel corso dei millenni,
per agevolare il ritorno delle forze del caos, cui diedero il nome di
Ancestrali o Grandi Antichi.
Carme per il giovane bardo
Ascolta, giovane e inesperto narratore,
le imprese immortali del Druida prescelto,
al cui nome tremano ancora
le Forze Oscure degli Antichi Sovrani.
In epoche buie, di cui è lecito appena
sussurrare il nome,
la Terra in cui vivi venne sconvolta
dal flagello dei Figli del Male.
Essi emersero dalla terra,
squarciarono il cielo,
e il Terrore seminarono tra Elfi e umani.
Ma i Saggi colsero un segno nel cielo stellato,
messaggero di morte e distruzione per il Nemico,
e forze ancestrali vennero in nostro aiuto.
Polvere divennero i Figli dell’Oscurità
eccelsa la gloria di chi li ridusse in cenere,
gravoso il dovere del bardo di renderla immortale.
Perciò prestami, o Ninfa ispiratrice
del canto sacro agli Elfi e alle Fate,
una misera parte della tua maestria,
perché i miei versi abbiano la forza
L’imperatore fantoccio
L’uomo magro, dallo sguardo scavato e dall'espressione nervosa, era seduto sullo scranno da diverso tempo, ormai; ogni cosa intorno a lui proseguiva imperterrita nelle sue attività senza senso, ma non riusciva minimamente a scalfire il suo mondo interiore.
La sala era sontuosamente decorata con uno stile pomposo, che ostentava lusso e potere per lasciare senza fiato l’umile visitatore proveniente da terre lontane; il soffitto a cassettoni, alto oltre venti passi, la sovrastava imponente: era dipinto con scene tratte dal sacro e dal profano, che narravano la creazione del mondo, la vita di grandi imperatori, i rituali di corte rigidamente scanditi da secoli di tradizione.
Due file di colonne di marmo dai colori accesi, decorate nei capitelli con complessi fregi in oro e bronzo, dividevano lo spazio in tre navate; mentre gli spazi laterali erano riservati alla servitù e alle persone di rango inferiore, l’enorme navata centrale costituiva il cuore pulsante della sala. Qui cortigiani, nobili, funzionari imperiali, ambasciatori e postulanti occupavano ogni giorno il pregiato pavimento di marmo, assediando l’imperatore e i suoi più alti dignitari con le loro questue, con richieste di sentenze, arbitrati e interpretazioni della legge. Era questa che regolava da eoni i rapporti tra i sudditi delle Marche orientali, il regno più ricco, prospero e civilizzato di tutto il mondo allora conosciuto.
Nessuno, tuttavia, avrebbe osato salire i cinque gradini che separavano la navata centrale dalla sala del trono, ove erano ammesse solamente le più alte cariche della burocrazia. Sul trono in oro massiccio, invece, sedeva unicamente l’imperatore, da tempo immemore simbolo del potere assoluto. Freddo, altero e distaccato, con uno sguardo impostato secondo un protocollo vecchio di secoli, egli ascoltava, annuiva e poi, con un semplice cenno della mano, chiamava a sé il funzionario competente per apporre il proprio sigillo su una decisione che nessuno avrebbe potuto (né osato) contestare.
L’uomo magro seduto sullo scranno, tuttavia, non era in grado di seguire le delicate e minuziose fasi del cerimoniale; in quel momento, egli era immerso in un mondo completamente avulso dal presente, fatto di ricordi e di ferite non rimarginate. Immagini, dapprima sbiadite, prendevano sempre più forma attorno a lui, come una nebbia onirica che lo riportava a eventi passati, ma ancora in grado di provocare sofferenza e disperazione...
In un’antica magione posta alla sommità di un altopiano, all’interno di un ampio salone da ricevimento, due giovani nella prima adolescenza stavano iniziando un piccolo rituale di corteggiamento, vissuto con l’emozione di chi prova sentimenti tanto intensi per la prima volta e non riesce a trovare il linguaggio, verbale o corporale, più adatto a esprimerli.
Il ragazzo era visibilmente impacciato e non riusciva a fare altro se non a farfugliare banali frasi di benvenuto, condite da espressioni affettate che si sforzavano di apparire galanti, senza però riuscire nel tentativo.
La ragazza ascoltava, con tenera condiscendenza, le parole del suo anfitrione, apprezzandone i goffi tentativi di seduzione con la tenerezza che hanno solo le donne più sensibili; e più guardava quell’adolescente balbettare timidi tentativi di poesia, più le brillavano gli occhi.
Poco importava che quell’incontro fosse stato organizzato da due delle famiglie più potenti dell’impero, quella dei Lascaris e quella dei Poliorketes (un tempo rivali), per suggellare una pace faticosamente raggiunta dopo tanti negoziati. Poco importava che il matrimonio tra i due fosse stato già stabilito da tempo per consolidare un’alleanza che avrebbe potuto cambiare le sorti del mondo.
I due si amavano in modo intenso e puro, quale a volte può sbocciare tra due bambini che hanno vissuto e giocato assieme per anni e che, sul limitare dell’età adulta, si accorgono che i loro sentimenti sono cambiati per trasformarsi in qualcosa di più poetico e più carnale allo stesso tempo; quel qualcosa che i cantori per millenni hanno cercato di definire e scoprire, rimanendo sempre al confine della sua natura più profonda: l’amore.
Forse alla maggioranza degli ospiti del maniero sarebbe apparso irrilevante che molti non vedessero di buon occhio quell’alleanza (già definita “sciagurata”) tra Lascaris e Poliorketes, perché tagliava fuori dal gioco del potere tante famiglie di nobile lignaggio che ambivano al trono imperiale, agognando di fondare l’ennesima dinastia.
Da quando l’impero era stato fondato, con la benedizione di un ormai vecchio e compassato Glynis, aveva costituito per secoli il baluardo della civiltà contro la barbarie dei popoli del Nord e l’eresia di Haimal, proveniente dalle terre orientali.
Il ruolo di guida e di punto di riferimento per tutte le terre del civilizzato Sud apparteneva – per generazioni grazie alle acclamazioni del popolo e al plauso degli intellettuali – alla figura dell’imperatore, considerata per questo sinonimo di grande levatura morale; salire sul trono significava farsi carico di enormi responsabilità e del destino di milioni di persone.
Con il trascorrere del tempo, tuttavia, l’ambizione, le gelosie e la sete di potere prevalsero sul senso del dovere e l’amore per il popolo. Famiglie intere avevano scatenato faide senza fine, con l’unico fine di consentire a un membro del casato di cingere la corona imperiale; non più per realizzare la missione di cui il reggitore dello Stato era investito da tempo immemore, ma solo per il prestigio e le ricchezze che ne potevano derivare.
Pochi storici, ormai, avevano il coraggio di citare le ragioni più recondite che avevano portato al Grande scisma, per la vergogna e il disonore che derivava dalla lettura di quegli avvenimenti storici. Le famiglie più in vista della regione occidentale e di quella orientale dell’impero, da tempo divise da rancori e aspre rivalità, non riconoscevano più l’autorità suprema dell’unico reggitore dell’impero.
L’elezione alla dignità imperiale di un membro di una famiglia rivale costituiva, per le fazioni sconfitte, motivo di scorno e frustrazione, nonché causa di ulteriori dissapori, intrighi e congiure di palazzo; senza tenere conto degli anatemi e delle scomuniche che il clero, pur in nome della stessa verità rivelata da Glynis, scagliava ora contro una ora contro l’altra delle famiglie che ambivano al trono, a seconda delle differenti e mutevoli alleanze che si formavano e disfacevano tra trono e altare, secondo uno schema antico come la Storia.
Alla fine, i territori occidentali dell’impero avevano ricusato l’autorità di Teodoro VII Lascaris, colpevole di aver usurpato il trono del legittimo pretendente, o forse di non aver concesso i favori promessi alle famiglie dell’Ovest. Le Marche occidentali (così si erano definite, in ossequio ad antiche nomenclature utilizzate dagli studiosi delle epoche passate) avevano deciso di disconoscere la legittimità dell’ultima dinastia regnante e di affidare le sorti del governo a un Senato, al quale avevano accesso tutti i capi delle famiglie di uomini liberi.
Le provincie a Est dell’impero, da allora note anche come Marche orientali, pur continuando a reclamare una formale signoria su tutti i territori un tempo posseduti, avevano preferito chiudersi a riccio nel proprio limitato orizzonte, del resto già minacciato dai predoni seguaci di Haimal e dall’ambizione di alcuni signorotti delle Terre desolate. Lo scisma, alla fin fine, costituiva per molti un vantaggio perché escludeva dalla lotta per il potere molti nobili occidentali e restringeva gli intrighi di potere a un più limitato numero di attori, anche se la posta in gioco era un impero ormai dimezzato.
Negli ultimi anni i Lascaris e i Poliorketes si erano spartiti la corona, macchiando il palazzo imperiale del sangue di molti pretendenti e reggitori; le lotte intestine erano proseguite sino a quando non era stata raggiunta, faticosamente, la pace tra le due famiglie, gradita al popolo ormai sfinito dall’interminabile faida, ma non ben vista da quei nobili che avevano acquisito sempre maggiori ricchezze e privilegi, sostenendo l’una o l’altra fazione.
Una solenne cerimonia, celebrando il fidanzamento tra Elisabetta Lascaris e Demetrio Poliorketes, avrebbe al contempo suggellato la pace duratura tra i due casati e la prosperità dello Stato. Proprio in quell’occasione, si stava consumando il timido corteggiamento tra i due ragazzi.
Tutto era poi avvenuto in pochi, terribili e interminabili istanti che avrebbero cambiato per anni le sorti dell’impero. Sinistri sicari ammantati di nero avevano fatto irruzione nel palazzo, fuoriusciti improvvisamente dalle profonde oscurità del nulla: silenziosamente, avevano circondato il castello con una malefica ragnatela fatta di inganno e tradimento, colpendo a morte chiunque avesse avuto la sventura di incrociarli.
Le lame baluginavano e il sangue scorreva in un’orrenda sinfonia di lacrime e disperazione; la strage era stata perpetrata ed eseguita con fredda e cinica spietatezza da uomini avvezzi a provocare atroci sofferenze, senza essere neppure sfiorati dal rimorso.
Quella notte sarebbe stata ricordata come il peggiore incubo mai prodotto dall’ingordigia, dall’ambizione e dalla assurda sete di potere. L’antica e nobile istituzione imperiale era degenerata definitivamente nel caos e nell’anarchia.
La maggior parte dei rampolli della nobiltà in grado di aspirare al trono avevano perso la vita in quei tragici momenti, lasciando l’impero quasi del tutto privo di pretendenti.
Demetrio Poliorketes venne ritrovato in un angolo delle stanze, pallido e tremante; batteva i denti come in preda ai deliri di una febbre malarica. Stava ancora stringendo teneramente tra le mani un fazzoletto di seta bianca, finemente ricamato con motivi geometrici color turchese, primo e unico pegno d’amore di una storia destinata a non avere un futuro. La sua mente non sarebbe stata più la stessa, da allora in poi...
Nei mesi successivi, molte teste erano cadute tra i membri delle famiglie accusate o semplicemente sospettate di aver preso parte alla congiura, ma questo aveva contribuito solo ad ampliare la spirale di lacrime e sangue in cui erano precipitate le ormai devastate Marche orientali.
La corona imperiale era stata posta sul capo di un giovane e ancora inesperto Demetrio Poliorketes, prigioniero dei suoi incubi. E l’impero precipitava nel disordine e nell’anarchia, vittima degli intrighi dei cortigiani che si spartivano le briciole del potere...
Il cancelliere richiamò nuovamente alla sua attenzione l’uomo magro seduto sullo scranno: «Eccellentissimo autokrator, il Suo imprimatur è richiesto per suggellare questa importantissima decisione del Concilio». Il funzionario tossicchiò, quasi a sollecitare una reazione del suo interlocutore.
Demetrio Poliorketes, undicesimo imperatore a portare quel nome, appose il suo sigillo sulla pergamena senza curarsi di leggerne il contenuto; del resto, anche la conversazione che aveva preceduto quella decisione gli era stata totalmente estranea. Pochi istanti dopo, la sua mente era di nuovo intenta a rovistare tra i suoi tarli e i fantasmi che la attorniavano...
“Molòn labè!”
Il capo delegazione degli Huni era giunto al cospetto dell’Imperatore Demetrio XI per negoziare la conclusione del conflitto.
Nei giorni passati, il rituale era stato a dir poco assurdo, anche per chi in passato ne aveva vissute di guerre e di battaglie. Gli Huni erano giunti in prossimità delle mura di Byze, senza incontrare resistenza; avevano montato il loro accampamento e preparato delle rozze macchine d’assedio, mentre l’esercito imperiale era rimasto del tutto passivo.
Quando l’ambasciatore dei barbari venne a palazzo a chiedere la resa incondizionata, i cortigiani pensarono che lo stato maggiore lo avrebbe fatto defenestrare con ignominia. L’infame Ciambellano, invece, aveva gelato l’uditorio chiedendo attenzione. “Il nostro Imperatore vuole prendere in considerazione le proposte di pace, per evitare inutili spargimenti di sangue. Il portavoce degli stranieri sarà pertanto ammesso alla presenza di Sua Maestà Demetrio XI per negoziare il trattato”.
Tutti ebbero un moto di stupore; dunque l’Impero scendeva a patti con i barbari senza neppure tentare di combattere? Non si era mai vista una cosa del genere, nel corso della quasi millenaria storia di Byze.
Eppure, il Ciambellano non si curava di quelle lamentele, alle quali si rifiutava di dare peso. Nella sua mente c’era solo l’immagine di Isabò, che aveva assunto uno degli aspetti più terribili: un mostro strisciante dai molti tentacoli dotati di ventose, pressoché privo di volto. In quella forma il Demone era in grado di suscitare il panico, qualunque essere vivente non poteva non percepire l’istinto primordiale di quell’entità, desiderosa di fagocitare qualunque cosa appagasse la sua perenne sete di energia.
Isabò era stato perentorio nell’ordinargli di far firmare all’Imperatore il documento che avrebbe sancito la resa incondizionata di Byze e consegnato la città e il suo reggente nelle mani degli invasori. E Lord Verminaard non aveva potuto fare a meno di obbedire...
L’ambasciatore degli invasori era ormai a pochi passi da un inebetito Demetrio XI, che continuava imperterrito a fissare il soffitto a cassettoni, mentre il suo Ciambellano tentava di spiegare i termini del negoziato: “Come già illustrato, mio Signore, le clausole del trattato appaiono nel complesso accettabili. In cambio di un formale ossequio al loro sovrano, gli Huni ci garantiscono la continuità delle nostre istituzioni e una piena autonomia. È chiaro che dovremo lasciare la città a disposizione per qualche giorno, per consentire ai loro soldati di approvvigionarsi”.
Il meschino uomo di corte aveva omesso uno dei punti del trattato: l’Imperatore doveva essere consegnato nelle mani dei vincitori, ai quali sarebbe stato conferito il potere di nominare il nuovo reggitore.
Demetrio XI allungò la mano facendo cenno di voler vedere il documento scritto; cominciò a consultarlo con espressione assente, che strideva con l’importanza e la fatalità di quel momento. Era quasi sul punto di sottoscrivere quel pezzo di carta così umiliante, quando cominciò a diventare paonazzo e a stracciare con studiata rabbia e violenza il documento, mormorando parole incomprensibili. Di fronte allo sguardo inorridito dell’ambasciatore straniero, Demetrio XI gli gettò in faccia i frammenti dei fogli strappati, gridando: “Molòn labè!”.
Il Ciambellano tentò di riprendere il controllo: “Ma, mio Signore... ne abbiamo già parlato a lungo assieme. Queste sono le clausole concordate per garantire una pace duratura tra i nostri due popoli”.
L’Imperatore continuava a fissare imperterrito il messo degli Huni, con sguardo fiero: “Molòn labè! Sai cosa significa, barbaro?”.
Il guerriero lo fissò con disprezzo, per lui Demetrio era un pazzo demente.
Al che, il sovrano lo incalzò: “Non lo sai? Allora lascia che ti spieghi, bifolco ignorante. Secoli fa, altri barbari vennero da Oriente per soggiogare il mio popolo. Un mio antenato presidiava il passo dal quale sarebbero sciamati gli invasori. Ebbene, tanta fu l’arroganza del re nemico che egli mandò un’ambasciata al nostro condottiero intimandogli di consegnare subito le armi. Vuoi sapere quale fu la risposta?”.
Il messo degli Huni, travolto da quel torrente di parole, esitò. L’Imperatore non gli consentì neppure di abbozzare una frase: “Molòn labè! In lingua antica significa ‘venite a prendervele!’. E oggi io dico la stessa cosa a voi barbari. Se volete Byze, venite a prendervela!”.
Mentre Lord Verminaard lasciava furente la stanza imperiale, l’ambasciatore completava l’antico rituale per dichiarare guerra; poi si girò senza una parola di commiato, allontandandosi.
Il folle Demetrio XI lo inseguì con una verga, stringendo nella mano sinistra i pochi frammenti di carta dell’armistizio sfumato. Egli continuava a urlare come un ossesso la frase che aveva rotto il suo lungo silenzio, anche quando l’ambasciatore era ormai fuori dal palazzo.
La folla incuriosita si radunò a contemplare quel bizzarro spettacolo. In poco tempo, buona parte della popolazione si era radunata attorno al suo sovrano, accompagnando l’umiliante uscita dalle mura dello sventurato messo con un sonoro e roboante: “Molòn labè!”.
Il Ciambellano era fuori di sé dalla rabbia. Non solo aveva dovuto subire uno scorno per la prima volta dopo anni, ma aveva anche fallito nella missione che gli era stata affidata da Isabò. Quel pazzo dell’Imperatore aveva scelto il momento sbagliato per ritrovare il bene dell’intelletto. Doveva occuparsi di lui al più presto, e non sarebbe certo bastata una soluzione provvisoria...





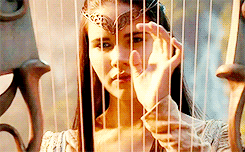





Nessun commento:
Posta un commento